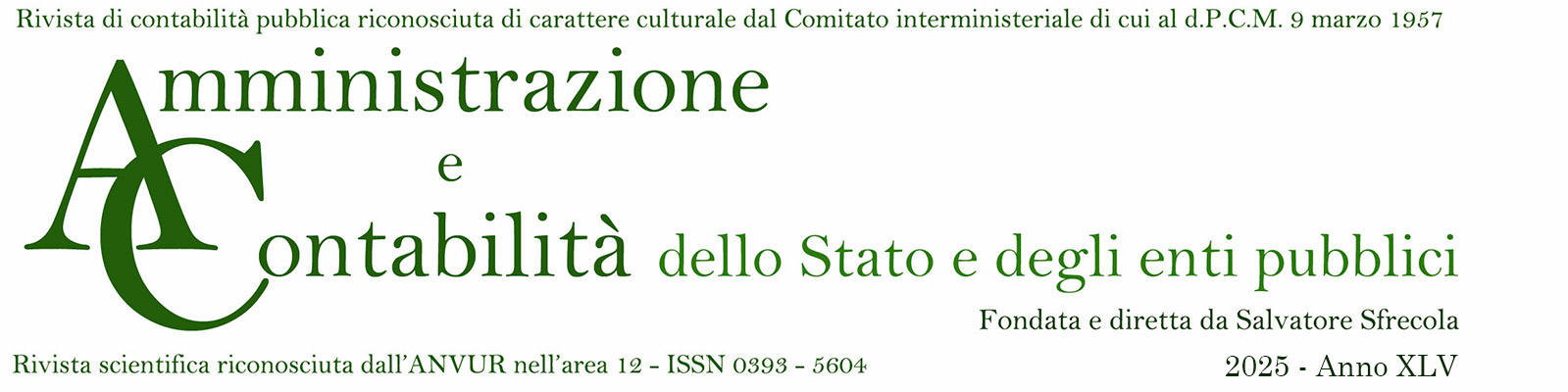di Mariagrazia Pellecchia, Magistrato della Corte dei conti
Abstract
Il presente articolo si propone di essere uno strumento pratico, utile, in primo luogo, agli enti locali che vogliono realizzare una Comunità energetica e che presentano alla Corte dei conti la richiesta di parere ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tusp), come modificato dalla legge n. 188 del 2022, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
In particolare, si sofferma sui requisiti che un comune deve analiticamente motivare affinché la Corte dei conti, in sede di controllo, si pronunci favorevolmente in ordine alla richiesta di parere pervenuta e sulla documentazione da presentare come, ad esempio, il piano previsionale, il business plan ed una relazione tecnica.
Tali atti, infatti, consentono al Collegio di avere una rappresentazione dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall’ente nonché di valutare la fattibilità tecnica del progetto, all’interno di un giudizio complessivo dell’operazione sotto il profilo del rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio secondo una prospettiva dinamica.
The aim of this article is to be a practical tool, useful, first of all, to local authorities that want to create an Energy Community and that submit it to the Court of Auditors the request pursuant to art. 5 of Legislative Decree No. 175 of 2016, “Consolidated Law on Public Participation Companies” (TUSP), as amended by Law No. 188 of 2022, “Annual Law for the Market and Competition”. In particular, it focuses on the analytical requirements so that the Court of Auditors, during the audit, pronounces favourably on the request received and on the documentation to be submitted such as the drawing up of development perpsective plans, the business plan and a technical report. The Court of Auditors considers the technical feasibility, the environmental sustainability and the economics of introducing alternative fuels to the market, with a representation of the direct and indirect costs incurred by the Municipality, making an overall assessment of the operation in terms of compliance with the principle of budgetary balance from a dynamic perspective.
- Premessa
Si prevede un numero sempre più crescente di richieste di pareri alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 del Tusp, per effetto della proroga dei termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi a fondo perduto erogati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nell’ambito della misura sulle comunità energetiche prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza M2C2 I.2.1[1], nonché di ulteriori bandi in merito.
In particolare, il decreto MASE n. 59 del 28.02.2025 ha esteso la scadenza della presentazione delle richieste al 30 novembre 2025 ed è, inoltre, in previsione l’erogazione delle agevolazioni anche ai Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti, con aumento potenziale della platea originariamente limitata agli enti al di sotto dei 5.000.
Considerato il termine limitato di 60 giorni entro cui la Corte dei conti deve rendere il parere ai sensi dell’art. 5 Tusp, è importante che gli enti locali che intendono realizzare una comunità energetica presentino una motivazione analitica sui requisiti previsti dall’ art. 5 del Tusp e tutta la documentazione idonea a supporto. La Corte, infatti, può avviare un dialogo istruttorio per avere un maggior grado di approfondimento di tali aspetti, ma ciò non sospende i termini entro cui il parere deve essere reso.
Le comunità energetiche costituiscono un modello di condivisione dell’energia, nonché di benefici ambientali, sociali ed economici, particolarmente diffuso soprattutto all’estero e disciplinato dal legislatore italiano attraverso il recepimento delle direttive europee[2].
In essa i partecipanti possono assumere la duplice veste di consumatori e produttori, “prosumers”, con il vantaggio di acquistare energia a prezzi inferiori rispetto al mercato e di poterla reimmetterla in rete, nel caso di eccedenza rispetto al consumo, attraverso il fornitore. Gli stessi mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.
Le CER hanno un aspetto certamente premiale, ma vista la loro natura ancora sperimentale in Italia, si impone al Giudice una valutazione ponderata in ordine a tutti gli aspetti che vengono in rilievo, a partire dall’impatto sui bilanci dei Comuni.
Rientrano nell’accertamento del Collegio anche gli elementi relativi alla gestione del patrimonio dell’ente, in quanto spesso gli enti forniscono alle società che realizzano le comunità energetiche terreni di loro proprietà, ad esempio per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, o prevedono diritti di superficie sugli stessi.
Alle volte si tratta di zone bonificate che ritrovano, con il progetto, una nuova utilità sociale. Tutti questi aspetti contribuiscono a delineare il quadro complessivo delle informazioni al vaglio della Sezione di controllo della Corte dei conti, oltre a rilevare ai fini delle responsabilità erariali conseguenti ad una cattiva gestione del bene pubblico in contrasto al generale principio di redditività che lo caratterizza.
Il presente elaborato è rivolto agli enti locali, in primo luogo, e agli amministratori che vogliono realizzare una CER nel territorio locale, e che, per questo, presentano la richiesta di parere alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 Tusp.
- Il controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016
L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all’acquisizione di partecipazioni dirette o indirette per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo, con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
La deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 ha, poi, fornito un orientamento generale con riferimento, in particolare, al riparto della competenza territoriale tra Sezioni della Corte dei conti nonché alla natura e oggetto della nuova tipologia di controllo.
In tale pronuncia si evidenzia la ratio di tale funzione che è quella di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.
Ciò “in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.
Il controllo in esame consente, inoltre, anche di intercettare tempestivamente eventuali criticità che, diversamente, potrebbero emergere solo in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 Tusp.
Qualora la Corte non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l’Amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 citato in caso di parere in tutto o in parte negativo, l’amministrazione può ugualmente costituire o acquisire la partecipazione come deliberata, purché motivi analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale.
In caso di parere negativo o parzialmente negativo, la comunità energetica può essere, dunque, ugualmente realizzata, salvo la motivazione analitica da pubblicare sul sito dell’ente. È bene ricordare, tuttavia, che il parere favorevole della Corte dei conti esclude la colpa grave nel caso in cui venga eventualmente in rilievo un’ipotesi di responsabilità erariale, nei limiti ovviamente in cui il parere è reso.
Spesso, infatti, proprio al fine di verificare in concreto se l’operazione di acquisizione della partecipazione o di costituzione della società per la CER sia conforme ai requisiti dell’art. 5 Tusp, questa viene sottoposta a monitoraggio nel tempo.
Quanto all’adempimento di cui all’art. 5, comma 2, del Tusp, la norma recita: “Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.
A tal fine non si ritiene sufficiente la pubblicazione della delibera comunale nell’albo pretorio, già prevista dalla legge, ma occorre che l’ente definisca le modalità di consultazione pubblica, con regolamento, preferibilmente coinvolgendo la cittadinanza attraverso questionari, proposte e raccolte di pareri.
- La motivazione analitica e la documentazione a supporto della richiesta di parere ai sensi dell’art. 5 Tusp
Gli oneri di motivazione analitica sono declinati dall’art. 5 del Tusp, in base al quale “…l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.
- L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”
A supporto della richiesta, è opportuno che l’ente presenti una serie di documenti riguardanti la società, come, ad esempio, il piano previsionale, specifico per il Comune ed almeno triennale, le visure camerali degli ultimi 3 esercizi, se non di nuova costituzione, ma anche lo Statuto ed il Regolamento.
Inoltre, è preferibile che la rappresentazione dei costi diretti ed indiretti per l’ente sia fornita in un business plan o documento equipollente. Quest’ultimo, ad esempio, deve indicare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo su chi gravano i costi di installazione degli impianti, se essi sono interamente recuperati o meno dal contributo MASE (o di altra natura) e/o dalla quota incentivi spettante al Comune, se viene presentata la relativa domanda di accesso al contributo PNRR; i costi di manutenzione (ordinaria e straordinaria); eventuali oneri (finanziari, nel caso di ricorso a finanziamento terzi con capitale di debito, o fiscali); le voci di ricavo, come quelli da energia condivisa, venduta e quelli derivanti dalla quota di incentivo del GSE spettante all’azienda in quanto produttrice di energia, il risparmio derivante dalla quota di energia prodotta dall’impianto e autoconsumata; i costi di gestione dell’impianto (variabili e fissi) e del soggetto su cui gravano; le previsioni economico-finanziarie complessive per il comune, oltre la tabella quota incentivi, comprendente, ad esempio, la quota di energia consumata e prodotta in euro, l’evoluzione del prezzo dell’energia elettrica, l’andamento di redditività per l’ente etc. È utile, altresì, indicare se si prevede o meno un fondo di solidarietà sociale.
La relazione tecnica, invece, serve per consentire al Collegio una valutazione sugli aspetti progettuali di realizzazione della Comunità energetica (cabina primaria, potenza impianto, utenza servita…) alla luce di un’analisi dettagliata dell’area (altimetria della zona; densità abitativa; localizzazione dei siti produttivi, criterio della vicinanza…) che tenga conto della specificità del territorio e delle risorse naturali per fini energetici presenti; dei consumi elettrici attuali e dei siti produttori di energia già esistenti, usando indicatori per qualificare i dati raccolti; della stima della riduzione di consumi tramite la realizzazione di misure di efficientamento energetico; dell’analisi economica a seguito della realizzazione della comunità etc.
Se l’ente decide di acquisire una partecipazione in una società (o di realizzarne una), deve inviare insieme alla richiesta di parere, lo Statuto, il Regolamento, le visure camerale almeno degli ultimi 3 esercizi, ed un piano previsionale almeno triennale che prospetti gli andamenti finanziari futuri della società. Quest’ultimo non deve essere generico, ma adattarsi alla peculiarità specifica del Comune in esame.
- La scelta del modello societario e la motivazione in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 175/2016
Gli articoli 3 e 4 del d.lgs. 175/2016 dispongono rispettivamente, che “le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa” e che “le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
Il comma 7 sancisce che “sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici…nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Ai sensi del primo comma dell’articolo citato “la deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (…) d) delibera dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche”.
Gli enti locali, nell’esercizio della loro discrezionalità, possono scegliere la veste societaria della Comunità energetica, che sia più idonea nel caso concreto a raggiungere il fine istituzionale che l’art. 4 del Tusp richiede di motivare.
La CER, infatti, può rivestire qualunque forma giuridica, eccetto quella della società semplice, per il pericolo, insito in quest’ultima, dell’illimitatezza della responsabilità dei soci.
La funzione di controllo della Corte dei conti ha, dunque, ad oggetto non la scelta societaria in sé, ma la motivazione della stessa in ordine al perseguimento del fine istituzionale.
Gli strumenti societari che più sembrano poter realizzare al meglio tale obiettivo sembrano essere la cooperativa, in particolare “benefit”, e la fondazione di partecipazione.
A volte, è lo stesso legislatore ad indicare una preferenza in tal senso, come accaduto per la Regione Calabria, con la legge n. 25 del 2020 “Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l’autoconsumo e l’autonomia energetica”, la legge regionale 19 maggio 2023, n. 20 recante “Modifiche e integrazioni alla l. 20/25” e da ultimo la recente legge n. 40 del 2 dicembre 2024 “Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità”.
La scelta, in questo caso, si spiega in ragione della presenza sul territorio di numerosi enti al di sotto dei 5.000 abitati, dunque piccoli comuni, in cui la cooperativa, per lo spirito mutualistico che la caratterizza, sembra la veste più idonea per la condivisione di quei benefici ambientali, sociali ed economici che la CER persegue.
Si potrebbe obiettare che, all’interno della stessa, l’ente, per il principio “una testa un voto”, non potendo esercitare i poteri di maggioranza, non riesca a determinare le scelte decisionali e strategiche.
La CER, tuttavia, nella visione del legislatore europeo e nazionale, è proprio uno strumento a servizio della collettività nel suo insieme, all’interno di un determinato territorio, ed in cui i partecipanti possono essere anche i cittadini, i centri commerciali, piccole medie imprese etc.
Pertanto, a contrario, il pericolo del modello della fondazione di partecipazione, in cui l’ente, in quanto fondatore detiene le sorti della Comunità energetica, può essere proprio quello di affidare solo al Comune la decisione di rimanere o meno all’interno della CER.
È noto, infatti, che quest’ultima si caratterizza per essere un soggetto autonomo di diritto in cui i soggetti, privati e pubblici, possono uscire e rientrare secondo “il principio della porta aperta”, liberamente e senza vincoli.
Tale scelta non può essere demandata solo ad uno dei partecipanti, in quanto chi ne verrebbe pregiudicato sarebbe proprio il privato cittadino, che trae il suo beneficio da una tariffa maggiormente agevolata rispetto a quella dell’ente, proprio perché lo scopo della CER è quello, tra l’altro, di combattere la povertà energetica.
In tal senso, invece, sembra più conforme il modello della cooperativa, in cui il sistema decisionale è partecipato in ugual modo da tutti i soggetti ed a cui meglio si addice il citato principio della porta aperta.
Oltretutto la qualificazione della cooperativa come “benefit” a responsabilità limitata, che trova la sua disciplina nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 376-383 e allegati 4 – 5, e successive modificazioni ed integrazioni, stempera il pericolo della preminenza delle scelte imprenditoriali in ragione della previsione statutaria del beneficio comune[3].
Ad ogni modo, la valutazione della Corte dei conti viene effettuata caso per caso, in relazione alla motivazione che l’ente fornisce in ordine alla scelta societaria più idonea a perseguire il fine istituzionale.
- Gli ulteriori requisiti motivazionali: le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; la compatibilità con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
La documentazione probatoria a supporto della richiesta di parere serve proprio per avere una rappresentazione chiara di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dal Comune, in una prospettiva dinamica di mantenimento dell’equilibrio di bilancio.
Per questo, la Corte dei conti, effettua un’analisi dei flussi finanziari della società che realizza la CER, in caso di acquisto di partecipazione, attraverso il piano previsionale e verifica che nello statuto e nel regolamento non vi siano clausole a sfavore per l’ente e per i partecipanti della Comunità energetica.
È importante, altresì, disporre del parere positivo del revisore e del responsabile del servizio finanziario. Anche il formulario dell’Agcom, in merito alla comunicazione, è un elemento valutativo per il Collegio. Ugualmente tale verifica viene condotta in caso di costituzione di una società per la realizzazione di una CER.
È sempre opportuno informare la Corte, insieme alla richiesta di parere, se si intende o meno presentare domanda per ottenere il contributo Mase o di altra natura, e rendere noti i benefici in termini di incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici.
È utile, poi, avere un prospetto dei ricavi in una tabella quota incentivi in termini di energia prodotta e consumata e sapere se è previsto o meno il fondo di solidarietà sociale.
Occorre specificare che, secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza, lo scrutinio sulla sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell’operazione, pur pieno e non meramente estrinseco, non può comunque estendersi all’area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all’Amministrazione, ma è volto a verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità.
Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria, in particolare, le Sezioni riunite hanno avuto modo di precisare che tale concetto “assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato” (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).
La valutazione deve effettuarsi anche in chiave prospettica, in considerazione dei limiti di cui all’art. 14 TUSP imposti al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato.
Sotto il profilo della convenienza economica l’ente deve motivare anche attraverso il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.
È preferibile che il Comune motivi sulla modalità di concessione dei terreni, in caso in cui si preveda su di essi la realizzazione degli impianti, specificando se vengono dati in locazione o in comodato, ad esempio, anche se tale aspetto può ben essere oggetto di scelta discrezionale motivata in un momento successivo.
Sotto tale profilo, è opportuno rammentare che nel nostro ordinamento vige il principio generale di redditività del bene pubblico, anche se esso può subire un’eccezione laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o ancor meglio superiore a quello soddisfatto dal modello generale di sfruttamento economico del bene.
Può essere il caso delle comunità energetiche, che, anche per l’assenza del preminente fine di lucro che le caratterizza, si prestano a costituire un’eccezione in tal senso, laddove il bene pubblico serva a realizzare il fine di svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio comunale.
L’Amministrazione è, infatti, libera di attribuire il bene anche al di fuori dell’istituto della locazione, dandolo ad esempio in comodato, nell’ipotesi in cui la concessione risulti più funzionale alla realizzazione di obiettivi pubblici, come nel caso di un’assegnazione in godimento di beni al gestore di un’opera o di un servizio, destinati alla collettività[4].
Tale interesse deve tuttavia essere motivato in concreto nell’atto che l’ente andrà a stipulare, anche con riguardo alla compatibilità finanziaria dell’intera operazione con la sua situazione economica e alle ragioni che consentono di ritenere recessivo l’interesse alla ordinaria fruttuosità di un bene rispetto al perseguimento di altri interessi pubblici ritenuti prioritari. Certamente, ad esempio, la messa a disposizione di una ex discarica in sito per gli impianti fotovoltaici per la realizzazione della CER, può rappresentare un elemento positivo di valutazione, ma va appunto inserita nel complesso della gestione dei beni comunali.
Tale attribuzione deve essere sempre conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale, altrimenti non troverebbe alcuna giustificazione.
In caso contrario, si prospettano profili di responsabilità del decisore pubblico, soprattutto per quanto concerne la compatibilità finanziaria dell’intera operazione alla luce della situazione economico-contabile dell’ente.
L’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016 stabilisce, infine, che l’atto amministrativo di acquisizione della partecipazione deve dare atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
Anche la predetta compatibilità deve essere supportata, da parte dell’Amministrazione, da un’adeguata attività istruttoria, volta ad evidenziare l’assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare[5].
[1] Cfr Decreto MASE n. 414 del 07.12.23 cd. decreto CACER come aggiornato – Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso TIAD – decreto MASE n. 106 del 15 marzo 2024 c.d. decreto corrispettivi
[2] Cfr. D.Lgs. 199/2021, di attuazione della Direttiva UE – 2018/2001 e dal D.lgs. 210/2021, di attuazione della Direttiva UE – 2019/944)
[3] Sul punto si veda il parere della Sezione di Controllo della Regione Calabria n. 11 del 2025. Sul modello della cooperativa benefit si rimanda alle pronunce della Sezione controllo della Corte dei conti del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto (FVG/52/2023/PASP; VN/117/2024/PASP; FVG/23/2024/PASP; FVG/25/2024/PASP).
[4] Cfr delibera Marche n. 161/2024/PAR
[5] Cfr. ex plurimis: Corte Cost., sentenza n. 142/2018.